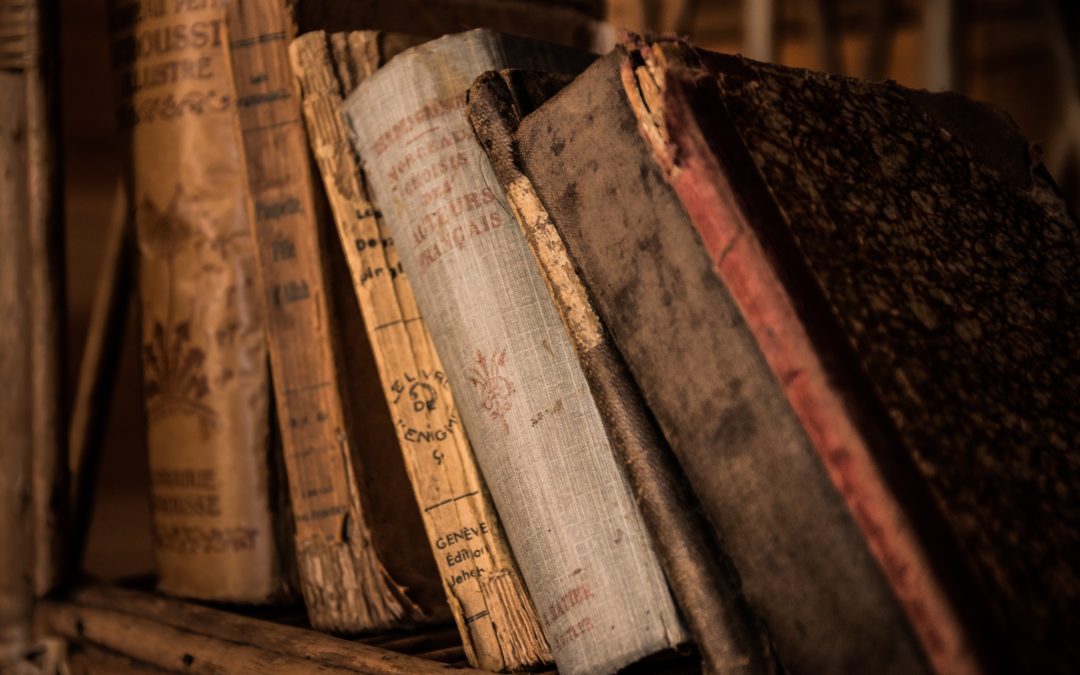da Simona Rosati | Dic 13, 2018 | Ansia, Depressione, Psicoterapia di coppia, Psicoterapia di Famiglia, Psicoterapia Individuale
Le feste in famiglia, se non emergono grandi problemi, creano risorse profonde dentro i bambini. In queste ricorrenze si può sperimentare un grande calore che in seguito verrà associato in futuro allo stesso periodo o a situazioni simili. L’essere umano prova angoscia al pensiero di essere abbandonato, soprattutto da piccolo. Vedere riuniti familiari ed amici dà una bella sensazione al bambino: se dovesse accadere qualcosa ai genitori, c’è lì qualcuno che potrebbe accoglierlo e prendersi cura di lui. E questa sensazione, soprattutto se l’esperienza si ripeterà, andrà a formare un nucleo di fiducia all’interno del bambino che lo aiuterà una volta divenuto adulto.
Stefi Pedersen, una psicoanalista, nella Seconda Guerra Mondiale condusse dei bambini ebrei in una traversata delle alpi che separano la Norvegia dalla Svezia, in inverno, per salvarli dalla deportazione. Una situazione non facile. I bambini erano arrivati in Norvegia da altre zone dell’Europa, erano profughi, quindi sapevano già come comportarsi e cosa fare: portare soltanto l’essenziale, uno zaino col cibo necessario per arrivare fino a destinazione e per vestiti solo quelli che indossavano.
Arrivati in Svezia, la Pedersen notò una cosa singolare: in fondo agli zaini, ormai vuoti, ognuno aveva qualcos’altro. Non erano oggetti preziosi, erano semplici decorazioni dell’albero di Natale, alcune fatte di cartone e stagnola (erano ebrei non praticanti, Natale per loro era una festa della famiglia, senza implicazioni religiose).
Possibile che bambini già abituati a lasciare tante cose dietro di sé, per dare la precedenza all’essenziale, avessero scelto di portarsi dietro oggetti simili? Sì. Quegli oggetti parlavano loro di momenti in cui si erano sentiti felici e al sicuro, erano la rappresentazione dei momenti buoni della vita, e davano loro la speranza che altrove, pur non sapendo ancora dove, avrebbero avuto altri alberi di Natale ad attenderli, altri momenti buoni. Erano ricordi che li avrebbero aiutati ad attraversare le avversità della vita con fiducia.
Ovviamente, è altrettanto vero il contrario: se in queste occasioni sono state sperimentate perdita, solitudine o frustrazione, sarà più probabile che da adulti si assoceranno queste ricorrenze a malinconia ed angoscia, una sorta di “depressione da evento” che riporterà a galla antiche ferite. E tornerà la paura di essere presenze non gradite.
Adesso veniamo a noi. Siamo adulti. Comunque siano stati i nostri Natali passati, siamo sopravvissuti abbastanza bene, almeno fisicamente, e siamo lontani da guerre. Cosa dovrebbe preoccuparci in questo periodo? Nulla, a parte le vacanze in cui affrontare clan familiari con cui non a caso di solito non interagiamo.
Cosa si può fare? Si parte per un paese lontano o si simula un malore? La fuga è sempre una soluzione, ma a lungo andare può essere stancante. Qualora si scelga di non fuggire, ecco alcuni spunti di riflessione o dritte per arrivare meno ammaccati possibile fino all’Epifania:
- Ascoltarsi bene per capire cosa si vuole, e, qualunque strategia si scelga di portare avanti, capire perchè e per chi lo si fa. Con una maggiore consapevolezza, le situazioni si affrontano in modo diverso: si sceglie in modo attivo e non si subisce ciò che ci accade.
- Ricordare che anche se i nostri parenti più o meno acquisiti non hanno modi che si sposano alla perfezione con il nostro sentire… quello è il loro modo di fare consueto, e non qualcosa di dedicato a noi. Noi inciampiamo in ciò che per loro è un normale modo porsi all’altro.
- Giocare d’anticipo con ironia: all’inizio del pranzo/cena si può prendere la parola per dire “Quest’anno sono ancora single, no, non cè nessun bambino in arrivo, la mia carriera è ancora ben lontana dall’esser definita brillante, vivo ancora nella casa dell’anno scorso, e come tutti possono notare non ho fatto alcuna dieta dimagrante. Quindi attenzione perché potreste dirmi le stesse cose dell’anno scorso (e come l’anno scorso non ascolterei i vostri mille consigli)”. Per agevolare gli scambi, potete suggerire eventi o situazioni nuove su cui potreste dilungarvi piacevolmente con racconti epici.
- Se proprio critiche ed interrogatori si fanno pressanti e non avete giocato d’anticipo, potete sempre:
– elargire sguardi eloquenti;
– spiegare tranquillamente ciò che si prova e che può essere frustrante subire un interrogatorio su alcuni aspetti della propria vita;
– convogliare l’attenzione su qualcos’altro di interessante che vi è accaduto;
– coinvolgere nella conversazione qualcuno che possa spalleggiarvi (questo essere umano c’è sempre da qualche parte) - Per arrivare in fondo alle giornate (nel caso si sia lontani da casa propria e non ci sia la possibilità di afferrare la valigia dopo il pasto pantagruelico) ci si può (deve) distrarre con boccate d’ossigeno più o meno metaforico:
– fare telefonate agli amici per commentare e sdrammatizzare il mal comune dei clan familiari;
– ritagliarsi del tempo per sé per andare in giro e chiacchierare con gente amica
Voi cosa farete? Come andranno le vacanze?
Io, intanto, sul mio albero di Natale ho già puntato una renna dipinta dalla inconfondibile mano espressionista di mio figlio. La metterò in valigia come buon auspicio sugli incontri, sull’autenticità nei rapporti umani e sulla buona digestione di tutto ciò che mangerò.
Bibliografia:
Bruno Bettelheim, Un genitore quasi perfetto, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1987.

da Simona Rosati | Nov 24, 2018 | Blog, Psicoterapia, Psicoterapia di coppia
Nelle coppie, chi più, chi meno, si tende tutti verso un ipotetico bilanciamento ideale di diritti e doveri (o almeno sarebbe carino tutti ci provassero). E ogni volta non si sa mai da che parte penderà l’ago della bilancia.
Quest’estate siamo stati in vacanza dalle mie parti in Abruzzo, sulla costa. Tanto per capirci, è il tipo di vacanza che mio marito detesta, ma si fa piacere perchè nostro figlio adora il mare.
Ad un certo punto mio marito ha fatto l’immancabile proposta di passeggiata in montagna: voleva vedere una cascata e per par condicio non si poteva dire di no.
Per arrivare alla suddetta fonte idrica, c’era un percorso definito “per famiglie”, quindi fattibile… col senno di poi, ho tanto la sensazione fosse per famiglie di camosci.
Dopo i primi 15 minuti la pendenza ha iniziato a farsi sentire ed il sentiero ha iniziato a riempirsi di roccia, tanto che in certi punti non si camminava più normalmente, ma si saliva appoggiando anche le mani a terra o tenendosi ai tronchi degli alberi.
Un altro po’ e mio marito ha iniziato a fermarsi e dire “Vabbè, se non ce la fate, lasciamo perdere”. Io ho guardato il bambino, che ce la faceva, valutato il mio stato di stanchezza e, nonostante dentro di me avessi un bradipo che si sbracciava come un naufrago su un’isola deserta al passaggio di una nave, ho insistito per continuare ad andare avanti.
Volevo sfidare la mia proverbiale pigrizia? Avevo un attimo di masochismo? Volevo far contento mio marito? Evitare le sue solite recriminazioni? Non lo so, un po’ tutto questo mescolato insieme. Continuavamo a camminare in silenzio, per risparmiare fiato ed energie, e, mentre mi chiedevo dove finisse la voglia di superare un mio limite e iniziasse l’andare al massacro, il mio umore andava via via scurendosi.
Ogni tanto mio marito continuava a dire “Vabbè, dai, torniamo indietro”, ma noi, io e mio figlio, andavamo avanti…finchè, dopo un’ora e mezza di sentieri, non ci siamo bloccati: abbiamo sentito un tuono, in un attimo io e mio marito ci siamo scambiati uno sguardo eloquente ed abbiamo fatto dietro front.
Tornando indietro il mio umore e le mie energie sono tornate a posto. Ci abbiamo provato, non è andata, ma non è stata colpa mia. Mio marito mi ha chiesto perchè non volessi tornare indietro ed io, che sono psicoterapeuta ma anche un essere umano come tanti altri, gli ho detto chiaramente che volevo farlo contento ed evitare che poi mi rinfacciasse di non avergli concesso la passeggiata in montagna.
E qui mi fermo un attimo e colgo la palla al balzo per parlare di due aspetti della comunicazione.
Il primo è la punteggiatura. Nelle interazioni a due ciò che fa uno può essere (è) contemporaneamente reazione a qualcosa e stimolo per una ulteriore reazione dell’altro, che a sua volta, in un ciclo ipoteticamente infinito, diventa un nuovo stimolo per una nuova reazione del primo. In base al modo in cui dividiamo e mettiamo l’accento su una piccola sequenza di questo processo, decidiamo in un certo senso “di chi è la colpa” se le cose vanno male (di solito dell’altro…noi siamo “innocenti” e stiamo solo rispondendo a, o difendendoci da, ciò che ci manda l’altro). In ogni momento, comunque, ognuno può decidere cosa fare: se continuare la sequenza o no.
Io avrei potuto insistere sul fatto, accaduto già altre volte, che poi lui avrebbe recriminato. Ma ho scelto di non farlo. Tutto sommato non è detto che ciò che è già accaduto debba per forza ripetersi.
Il secondo aspetto è la metacomunicazione, ossia il comunicare su ciò che accade in un processo di comunicazione, a livello più profondo. La comunicazione è costituita sempre da due parti, una che riguarda il contenuto, le informazioni che passano da una persona all’altra, ed una che riguarda la relazione che c’è tra le persone e come vanno interpretate le informazioni che sono state passate. L’aspetto di relazione definisce che tipo di legame c’è tra le persone e indirettamente serve a definire se stessi.
Cosa è successo in questo caso, tra i sentieri di montagna? Abbiamo iniziato a parlare di ciò che credevo io e ciò che si aspettava lui, della mia sensazione che quella vacanza non fosse molto distensiva per lui, sia per il mare, sia per il full immersion con la mia famiglia d’origine. Io mi sentivo in difetto con lui e cercavo di renderlo contento in un modo che poco aveva a che fare con la mia idea di vacanza… e questo mi rovinava l’umore. Tutto questo è accaduto dentro di me, senza che ne fossi cosciente, e avrebbe potuto sfociare in una discussione potenzialmente infinita.
Lui come ha risposto alla mia sincerità? Tranquillo e sereno, un po’ stupito, mi ha detto che in realtà andare al mare non era poi tanto male e che gli bastava essere stati un pomeriggio tra i boschi per dirsi che si era fatto un po’ di vacanza in montagna. Non mi avrebbe detto nulla se avessimo rinunciato prima al percorso, ed effettivamente sono passati mesi e non mi ha rinfacciato alcunchè.
Tornando a casa ho pensato a quante volte nella vita facciamo degli errori di valutazione, diamo per scontati i desideri, le intenzioni degli altri, portiamo avanti qualcosa trascinandoci e manifestando rancore e poi… poi gli altri avevano altri desideri ed altre intenzioni e tutta la nostra fatica poteva essere evitata.
Per ora solo una cosa è certa: non siamo arrivati fino alla cascata e l’anno prossimo ci sarà il rischio di riavere in ballo l’obiettivo non conseguito. Vabbè, l’anno prossimo vedremo cosa succederà e in quali itinerari dovrò traghettare il mio bradipo interiore.
Bibiografia
P. Watzlawick, J. Helmick Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, Casa Editrice Astrolabio, 1971.

da Simona Rosati | Apr 19, 2018 | Ansia, Blog, Disagi Psicologici, Psicoterapia, Psicoterapia Individuale
Telefonata. Una mia amica è un po’ in crisi. Ha fatto mille cose andate bene nelle ultime ore. Ma è certa che sia stata solo fortuna, il caso, ad avvantaggiarla ed è convinta che qualcosa stia per andare storto e tutti si accorgeranno che le sue attività fanno acqua da tutte le parti.
La conosco bene. Non è così. È brava ed è la tipa che la sera mette a dormire le sue bimbe e poi riaccende il computer per mettersi a studiare qualcosa che non padroneggia ancora in modo perfetto o per approfondire un aspetto marginale del suo lavoro che ancora le sfugge.
Mi chiedo perché faccia così. Semplice insicurezza? Mi sembra troppo poco e comunque, quando manifesti questo aspetto, non hai paura di essere smascherato. Ti limiti a sperare che tutto vada bene per non far brutte figure. Non temi di essere “scoperta”.
Approfondisco e mi imbatto nella Sindrome dell’Impostore.
“Ma come? Sei una psicoterapeuta e non sai a memoria tutti i disagi umani?”
“No, non li conosco proprio tutti tutti, e sono sempre in tempo per documentarmi.”
La dinamica è stata analizzata per la prima volta nel 1978, nell’articolo di due ricercatrici (Pauline Rose Clance e Suzanne Imes) e negli ultimi 40 anni si può dire che non ci sono state particolari variazioni.
Si tratta di un disagio che colpisce le donne nella maggior parte dei casi. In parte c’è anche una sorta di substrato culturale e di genere alla base della sua insorgenza.
Le persone che manifestano questo problema, nonostante i grandi traguardi accademici e professionali ottenuti, si sentono sopravvalutate, poco intelligenti e credono di aver raggirato chiunque non la pensi così sul loro conto. In virtù di questa loro credenza, vivono nell’angoscia che qualcuno si svegli e capisca di esser stato truffato.
Due differenti storie familiari sembrano essere alla base di tutto ciò.
Nel primo caso, nel contesto vitale c’è l’idea, sbagliata, che il brillante della famiglia sia un altro, e che la persona che svilupperà il disagio deve essere competente nelle relazioni sociali, non può eccellere per intelligenza. Da un lato lei fa suo questo stereotipo, dall’altro cerca comunque di eccellere nello studio e a livello professionale, ritrovandosi nel bel mezzo di un conflitto interiore.
Nel secondo caso, fin dall’infanzia è stato passato il concetto che non c’è nulla in cui la persona non riesca. E’ perfetta sotto ogni punto di vista, a prescindere.
Ovviamente nessuno è perfetto, e con l’inizio della scuola si comincia a capire che ci sono discipline in cui per essere bravi, bisogna faticare. In quel momento, visto che c’è l’assunto che se si è perfetti, lo si è senza sforzo, la persona comincia a dubitare delle proprie capacità, tutte. Fino a dubitare anche del giudizio dei genitori, e visto che non sono stupidi o impazziti, il portatore del disturbo ritiene di averli raggirati.
Torniamo alla mia amica. La richiamo e le chiedo della sua famiglia, quando era piccola. No. Non c’era nessun altro di brillante a prescindere e lei non era perfetta per i suoi genitori, tutt’altro. Ricorda che la madre si lamentava del suo eccesso di entusiasmo e del fatto che non portava nulla a termine. Solo da grande, non da molto, ha capito che non è vero che non porta a termine ciò che comincia… Quando l’ha realizzato, si è sentita molto sollevata.
Cosa si può fare per uscire da questo circolo vizioso in cui non si crede di essere abbastanza intelligenti, si lavora duro e conseguono traguardi per cui non si pensa di essere adeguati, e si continua a lavorare sempre più duro col terrore di essere “scoperti”?
A livello di terapia, il campo d’elezione è certamente quella di gruppo, perché offre un confronto costante, ma ci sono strategie che possono aiutare almeno a riflettere un po’ su se stessi:
Non prendersi troppo sul serio, perché nessuno è perfetto e tutti possono sbagliare. Può capitare, e non è il caso di farne un dramma
Dirsi, ad alta voce “Sono brillante!” e vedere che effetto fa. Ci si sente arroganti, snob, esibizionisti o, in caso di donne, poco femminili? Questo offre spunti su cui riflettere ulteriormente.
Nel caso in cui si ritiene di aver conseguito i propri obiettivi attraverso il proprio fascino o compiacendo gli altri, cambiare impostazione e provare a dire ciò che si pensa, anche se è controcorrente, e vedere cosa accade. E’ possibile che non accada nulla di negativo.
Contattare chi ha già lavorato con noi, chiedendo espressamente cosa pensino di noi e delle nostre capacità. Si potrebbe scoprire di essere piacenti, socievoli, ma anche intelligenti.
Mettere per iscritto ciò che si pensa di sé, fino in fondo, anche esagerando un po’ su alcuni punti. Da un lato si ‘intrappola nella carta, all’esterno’ il disagio e lo si può guardare prendendo un po’ le distanze, dall’altro chissà che rileggendo quanto scritto non si sorrida un po’ di se stessi.
Ma la mia amica come lo gestisce il problema? Quale strategia le offre maggiori vantaggi?
Gliel’ho chiesto, lei ci ha pensato su e poi mi ha detto “Parlarne con altre persone. Condividere le mie sensazioni. Perché da un lato scopro di essere meno sola, visto che altri hanno il mio stesso disagio, e dall’altro, mentre ascolto le insicurezze infondate degli altri, mi viene in mente che anche le mie sensazioni possono essere lontane dalla realtà.”
Questa strategia mi è piaciuta, ringrazio di cuore la mia amica e… chissà che non possa tornare utile a qualcun altro.
Bibliografia
Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The imposter phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 15(3), 241-247
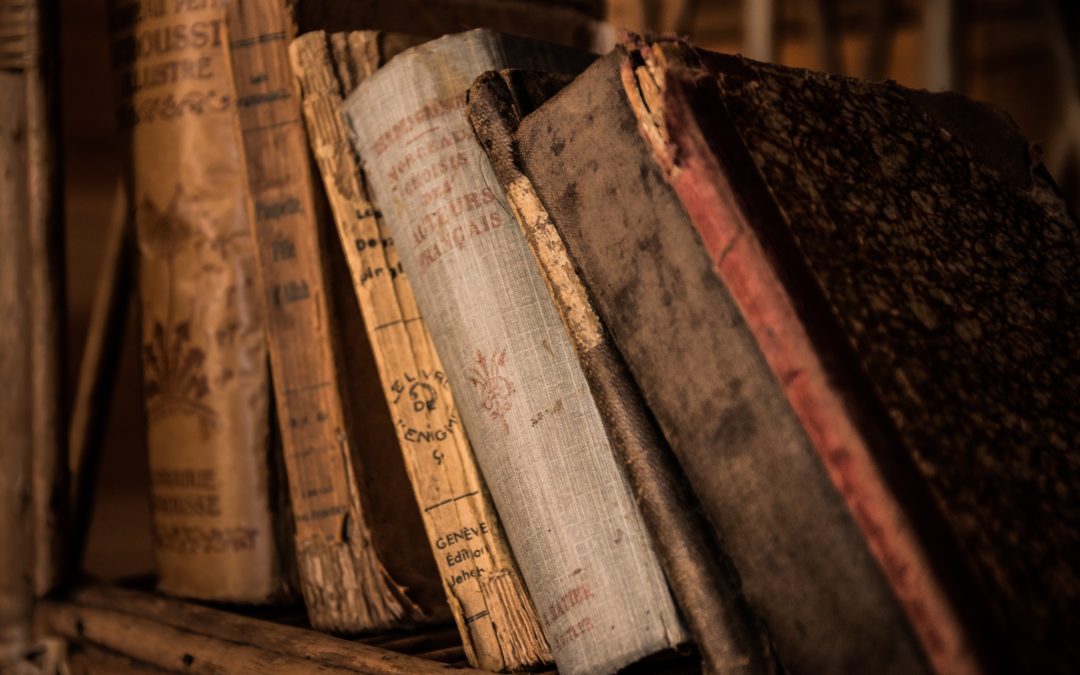
da Simona Rosati | Mar 30, 2018 | Blog, Consulenze, Psicoterapia, Psicoterapia Individuale
Quando mi sento felice, perché ho avuto una bella giornata e le cose si sono incastrate tutte bene, qualcosa dentro di me comincia a canticchiare una canzone: My favourite things. E’ un po’ la mia muta e personale colona sonora delle giornate andate bene.
Spesso si pensa “se questa cosa cambiasse…se quella persona fosse qui…se ottenessi il lavoro che dico io…sarei felice”. Mah. Realizzare un desiderio è sempre bello, ma poi magari ci si rende conto che manca ancora qualcos’altro, che forse non siamo all’altezza della nuova situazione e allora? E allora si ricomincia da capo.
La scorsa estate, nonostante gli incastri della vita non fossero propizi, mi sono iscritta ad un corso di restauro libri. Quel corso mi ha reso felice? Sì, ma non perché il corso fosse una panacea (a me è piaciuto tanto, ma non siamo fatti con lo stampino), semplicemente perché ad un certo punto ho dato uno strattone e mi sono ricavata (sostenuta da mio marito) uno spazio mio, solo mio. In cui non ero la psicoterapeuta, la mamma, la moglie, la figlia o quella che deve correre a destra e manca per mettere le toppe. Ero io soltanto a “giocare” con carta, colla e attrezzi quasi alchemici.
Tutto ciò mi ha reso felice, davvero? No, però mi ha alleggerito.
E mi ha fatto venir voglia di approfondire questo stato d’animo.
Cercando qua e là, mi sono imbattuta in un libro che già avevo in casa. Un libro semplice, chiaro, ironico. In una parola Fantastico. In cui si parla di…tutto ciò che sarebbe meglio fare per essere infelici.
E lì ho capito una volta di più che essere felici non è un momento, ma un processo. Non è il risultato, ma ciò che faccio per arrivarci e come. Non è il corso di restauro libri, ma io che do uno strattone e mi ritaglio uno spazio solo mio con la complicità di mio marito e mio figlio che dice orgoglioso agli amichetti che io “aggiusto libri”.
Le persone che vanno in terapia, tendenzialmente alla fine del percorso (se arrivano fino alla fine) stanno meglio. Perché qualcosa si è acceso all’improvviso dentro di loro? Anche. Perché a volte ci sono insight stravolgenti. Ma soprattutto perché hanno deciso di prendere in mano la loro vita e farci qualcosa di costruttivo. Senza quel qualcosa di preparatorio, neanche il migliore insight del mondo troverebbe un varco da cui offrire uno spiraglio di luce.
Nel libro trovato in casa si approfondiscono vari aspetti. Qui mi concentrerò solo su un aspetto: il tempo e come lo usiamo.
Spesso noi vediamo il passato come unico momento aulico e degno di nota della nostra vita. Non conta ciò che è accaduto in realtà. Il passato è sempre migliore del presente, a prescindere. Ci focalizziamo su ciò che andava bene e il presente non sarà maaai alla sua altezza.
La conseguenza dell’essere rivolti al passato, è che non ci restano né tempo né risorse per ciò che occorre fare adesso, nel presente. Siamo troppo occupati dalle recriminazioni e dalla lamentela per ciò che, secondo noi, abbiamo perso, da non pensare a ciò che abbiamo e potrebbe portarci altra felicità. E’ un po’ come camminare guardando indietro. Si va più piano ed è inevitabile trovare degli inciampi.
Me ed il corso di restauro libri: una volta avevo taaaaanto tempo libero, avrei potuto farlo prima il corso, e adesso sarei stata l’essere più felice dell’universo. Come direbbe mio figlio….Macchè?! Ero sempre presa da seminari, corsi, lavoro, su cui si intersecavano dilemmi esistenziali… non proprio una pacchia. Infatti quest’estate mi sono fermata e detta “non è vero che prima avrei avuto il tempo, il tempo, se davvero voglio farlo, posso trovarlo, ora, non importa come!” e così è stato.
Un’altra cosa che non facciamo per essere felici, senza rendercene conto, è non accettare tranquillamente ciò che ci offre la vita adesso, nel presente. E’ una cosa un po’ strana, prima volevamo qualcosa, quando quel qualcosa arriva…ecco che non lo vogliamo più, quasi che la nostra vita non sia più compatibile con la soddisfazione di quel bisogno o desiderio. E’ capitato anche a me. “Ormai ho più di 40 anni, ma dove vado? Ho già un lavoro, che mi metto a fare?”…per fortuna avevo davvero dei libri da rimettere in sesto e la mia soddisfazione nel presente ci sarebbe stata comunque.
L’ultima situazione legata al tempo è…che solo perché in passato una soluzione è stata valida, non è detto che lo sarà anche adesso o in futuro. Qui l’autore del libro, Paul Watzlawick, racconta una storia molto simpatica che vorrei riproporre.
C’è un ubriaco che perde le chiavi casa. Le cerca e arriva un’altra persona che comincia ad aiutarlo. Mentre girano sotto un lampione da diverso tempo, il secondo arrivato gli chiede se sia sicuro di averle perse lì, sotto il lampione. L’ubriaco lo guarda e fa “No, le ho perse dietro un cespuglio, ma lì è buio pesto, meglio cercare qui che c’è più luce.”
La storia è simpatica e il protagonista è ubriaco, quindi non nel pieno possesso delle sue capacità mentali. Ci viene da dire “Eh, ma io non sono mai andato a cercare sotto un lampione ciò che sapevo essere dietro un cespuglio.”
Già. Ma quante volte abbiamo pensato che la nostra felicità fosse in un incarico di lavoro specifico, una relazione sentimentale con un partner in particolare o in qualcos’altro e una volta ottenuto….ci siamo accorti che non eravamo felici manco per idea?
Io, intanto, che fine ho fatto?
Ho finito il mio corso, restaurato un libro con grandi soddisfazioni, non sono diventata una restauratrice, ma…ho imparato qualcosa di nuovo, di pratico e su me stessa. Ho imparato a zittire quella vocina maligna che mi dice che non posso, non è il caso e “ma dove vado?”
Non ho raggiunto nessun livello di non ritorno sulla mia strada verso la felicità, ma certamente ho imparato qualcosa che mi aiuterà ad avvicinarmici un po’ di più di ieri… perché ieri, a dispetto delle mie false illusioni, certamente non ero più felice di oggi.
BIBLIOGRAFIA
Paul Watzlawick Istruzioni per rendersi infelici, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1984

da Simona Rosati | Mar 30, 2018 | Blog, Psicoterapia, Psicoterapia Individuale
Quest’estate ho passato più tempo del solito nella mia cittadina di origine, e mi sono ritrovata varie volte ad ascoltare il racconto di vita, morte e miracoli di persone non presenti. Io ho ricoperto il ruolo di uditrice più o meno attiva.
Un giorno ero affacciata ad un balcone e chi mi faceva compagnia, accennando ad un uomo che aveva appena parcheggiato in strada, ha detto “eccolo che torna, va dalla tipa del secondo piano…sono amanti”
io “ah, è sposato con un’altra?”
“no, è separato da un bel po’”
“allora è lei che sta con un altro?”
“no, anche lei è divorziata da anni, si sono conosciuti che erano già liberi”
io, perplessa “ah, allora stanno insieme, non sono solo amanti”
“eh…e che ho detto io?”
“no, credimi, hai detto un’altra cosa…se stanno insieme e nessuno dei due ha un altro non è il caso di parlare della loro storia come se fosse una tresca…”
Finita la vacanza, ho deciso di approfondire il tema del pettegolezzo, a livello antropologico, filosofico e psicologico. Ed ho scoperto cose a cui prima non avevo mai prestato particolare attenzione.
Il primo aspetto che emerge è quello del creare alleanze e relazioni. Si parla di qualcuno, CON qualcuno. E in questo scambio avvengono 2 cose. Chi racconta, dice ciò che pensa di quella persona in quella situazione, quindi trasmette qualcosa su di sé, le sue credenze ed i suoi valori, ma, attenzione, senza esporsi, senza dire ufficialmente “io sono così e la penso colà”. Questo modo di fare evita di incorrere in rappresaglie, perché c’è solo un racconto, qualcosa di indiretto. Il secondo aspetto è che in base alla reazione dell’altro, viene a crearsi una sorta di mappatura sociale. Chi racconta, da un lato indica da che parte si trova rispetto alla storia, spesso si dissocia da ciò che è accaduto, e dall’altro sonda qual è la posizione del suo interlocutore. Cosa ne pensa di ciò che è accaduto? Da che parte sta?
Un’altra caratteristica particolare è che a volte qualcosa, un dettaglio, viene alterato, per far sì che si venga a creare un nuovo senso, certamente negativo e che non lasci spazio a interpretazioni alternative. In questo caso l’obiettivo, più o meno latente, diventa il danneggiare o creare uno svantaggio per la persona su cui si confabula.
Visto che il pettegolezzo è un attacco indiretto, che aiuta il controllo sociale evitandone le possibili ritorsioni, può non essere apprezzato, buttando addosso a colui che lo utilizza la nomea di debole che attacca senza esporsi.
Pensiamo a cosa stava accadendo a me, nel momento della confidenza iniziale. C’era qualcuno che mi stava esponendo una specie di giudizio negativo su un comportamento, ma senza alterare effettivamente i fatti (non ha inventato storie di tradimenti extraconiugali o altro). Quindi? C’era un tentativo di dissociarsi, ma senza voler creare danni. Forse, sotto sotto, non c’era l’obiettivo della distruzione della posizione della dirimpettaia. Anche chi mi riportava i fatti, a dirla tutta, è divorziata, quindi perché esprimere un giudizio negativo? Per sottolineare che lei appartiene ad un’altra categoria di donna italiana divorziata? Mah…
Andiamo oltre. Un altro aspetto del pettegolezzo, più psicologico, consiste, invece, nello spostare l’attenzione da sé su qualcos’altro. E’ un modo come un altro per non esporsi. Sembra quasi che la persona dica “ti racconterei tanto di me, ma non sai cosa è accaduto a quest’altra persona…prima ti racconto il fatto sensazionale, e poi ti dico di me”, ma spesso il momento in cui si mette da parte il sensazionale altrui non arriva.
Torniamo sul balcone. Analizziamo di nuovo cosa stava accadendo, mettendoci dentro anche la sequenza temporale, il prima ed il dopo.
Finalmente eravamo sole, sul balcone, in un momento tranquillo. C’erano tutti i presupposti per parlare un po’ di sé, di come va la vita e via dicendo, ma forse, per un motivo qualsiasi, lei non aveva voglia di farlo.
Di solito questo può accadere per due motivi (ammesso che ci sia confidenza e voglia di stare con quella persona): o c’è qualcosa di doloroso che non si ha voglia di condividere, oppure non si è abituati a condividere qualcosa di sé (e magari neanche a pensarci tra sé e sé). In quel caso il pettegolezzo assume tinte e sensi differenti. E può rimandarci qualcosa di significativo sul mondo interno del nostro interlocutore.
Non si può entrare nella vita delle persone sfondando la porta, ma si può metterlo a proprio agio in nostra compagnia, e magari, piano piano, prima o poi, avrà voglia o riuscirà a condividere con noi qualcosa di importante. Con calma, senza fretta, magari usando un po’ di ironia, potremo anche strizzargli l’occhio e dirgli “ok, mi hai raccontato i fatti di tutto il quartiere, adesso mi dici qualcosa anche di te o tu hai cambiato casa e non abiti più qui?”
bibliografia
Feinberg Matthew, Willer Rob, Stellar Jennifer, Keltner Dacher, “The virtues of gossip: Reputational information sharing as prosocial behavior”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 102 (5), May 2012, 1015-1030.
Alessandro Catania “L’interpretazione del pettegolezzo” in Ocula, Vol 10, Dic 2009.

da Simona Rosati | Mar 29, 2018 | Blog, Consulenze, Neogenitorialità, Psicoterapia, Psicoterapia di Famiglia
Tempo fa mi sono ritrovata a parlare con un’altra mamma al parco. Mio figlio è abbastanza temerario e si arrampica dappertutto, anche se con criterio (almeno finora…). Il figlio di quest’altra donna voleva seguirlo e fare qualcosa che per lei era pericoloso, quindi “No, non farlo! Mi fa preoccupare vederti fare questa cosa, e tu non vuoi che io mi preoccupi, vero?”
Obiettivo raggiunto! Il bambino ha desistito immediatamente.
Poi, rivolta a me “Sono fiera di come ho impostato la sua educazione! Gli comunico il mio stato d’animo e lui, per non farmi star male, non fa ciò che non deve fare. Lo aiuto a mostrare empatia verso gli altri.”. Io sono rimasta basita, ma per quieto vivere non ho detto nulla. Non ero abbastanza in confidenza per comunicarle la mia opinione in merito.
‘Avere una reazione empatica significa sforzarsi di metterci nei panni dell’altro, così che i nostri sentimenti ci facciano intuire non soltanto le sue emozioni, ma anche le sue motivazioni. Significa comprendere l’altro dall’interno, non dall’esterno […]'(Bettelheim)
Possiamo capire le emozioni di un’altra persona se le abbiamo già provate dentro di noi, ed abbiamo imparato a mettere tra noi ed esse (le emozioni) la giusta distanza, quella necessaria per guardarle da fuori e riconoscerle.
Il bambino, a 4-5 anni, è ancora piccolo per guardarsi dentro, non riesce ancora a capire bene cosa si muove dentro di lui, figuriamoci dentro qualcun altro.Attenzione, non dico che non si può parlare di emozioni ad un bambino, anzi. Semplicemente in questa fase si può aiutarlo nel riconoscimento di ciò che accade dentro di lui, in ‘pancia’, mettendo da parte le pance degli altri, che aggiungerebbero solo confusione. Gli adulti hanno un ruolo importante e delicato, perché occorre mettersi da parte e non dare indicazioni che si sovrappongono al loro sentire, altrimenti le loro emozioni restano delle incognite sotterranee che ogni tanto esplodono lasciando perplessi e impotenti.
La mamma che ho incontrato aveva certamente le migliori intenzioni, ma le sue parole insegnavano altro: a fare qualcosa per dare un piacere o togliere un dolore a qualcun altro. In altre parole il bambino impara a compiacere senza comprendere cosa sente e cosa vuole. Questo non è un dettaglio irrilevante. E’ qualcosa che forgerà e incasellerà molte cose che arriveranno anche dopo, negli anni.
Più o meno consapevolmente ogni genitore vorrebbe che il figlio fosse uguale a lui, pensasse le sue stesse cose e le sentisse allo stesso modo. E quale modo più semplice se non quello di dargli una mappa già predisposta?
La vera vittoria sta nell’aiutarlo a trovare la sua strada, il suo percorso, affinché lui si costruisca la sua mappa. Mi viene un po’ da sorridere pensando a certi navigatori satellitari che non tengono conto del territorio ma solo della mappa. Spesso viene indicato come unico percorso una strada che si rivela essere una scalinata (ma siamo in auto), oppure favorita una soluzione senza tener conto di caratteristiche particolari (salite o discese) che possono rallentare notevolmente la tabella di marcia. Ecco, quando noi adulti diciamo ai bambini cosa devono sentire, ci trasformiamo in navigatori che dicono di andar per campi.
Il problema è che poi, se non si impara a gestire tutto il marasma che abbiamo dentro, non è che di punto in bianco, un bel giorno, ci si sveglia sapendolo fare. Una mattina ci si sveglia e non ci capisce se ciò che ci ha mosso la sera prima nel discutere col partner sia stata rabbia, vergogna, umiliazione o bisogno di esercitare potere sull’altro in un momento di debolezza. Ci si sveglia e c’è solo la sensazione che qualcosa sia andato storto, non si sa cosa. Invece di usare una mappa già pronta, sarebbe stato meglio perdere tempo ed energie nell’imparare ad orientarsi nello spazio, nel tempo, e perché no?, dentro di sé.
BIBLIOGRAFIA B. Bettelheim “Un genitore quasi perfetto”, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1987.